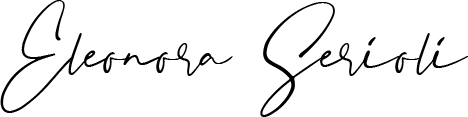SE NON CERCHI, NON TI PERDI
Se mi conosci, già lo sai.
Se non mi conosci passerà pochissimo prima che tu possa accorgerti che oltre a dovermi nutrire di bello ed estetico, devo farlo in modo serio e continuo con il buono.
Il buono credo sia diventato per me quel rifugio sicuro fin da quando ho avuto un’età che mi permettesse di capire che fosse una delle poche nuvole felici sempre a disposizione indipendentemente dalle circostanze della vita.
Le cotolette di nonna, le lasagne di papà, la pizza d’asporto, la colazione fuori se non ho nulla in frigo.
Posso concedermi qualcosa di buono ogni volta che ne sento il bisogno
Ad un certo punto della vita ho iniziato a sentire la necessità che il buono, soprattutto durante i miei viaggi, diventasse anche locale, identitario, sincero, armonioso, e che potesse essere di conseguenza memorabile.
La Sardegna m’è entrata lì dov’è anche per questo: custodisce una palette culinaria così ampia e piena di tonalità da diventare sempre un secondo viaggio dentro al viaggio.
È una certezza il fatto che vestita solo della sua geografia straordinaria fatta di tutti i blu e i verdi e gli ocra esistenti al mondo, senza la sua identità enogastronomica così forte, non mi avrebbe provocato la stessa crepa nel cuore.
Lo custodisce e protegge proprio con fierezza questo filo intrecciato tra tradizione e territorio che resiste, seppur piegandosi a tratti, alle minacce di un settore ristorativo che non ha più tempo di rallentare e capire da dove veniamo.
In questa terra disegnata dal vento e dalle conquiste di chi quel vento l’ha seguito, cucinare e mangiare sono un atto di identità, un modo per raccontare millenni di storia nella durata di un pasto.
“Parla come mangi” ma soprattutto “mangia come sei, ricordi, sai, vivi”.
Per poterlo fare però, forse, chi sei lo devi prima scoprire.
La ricerca matta e disperatissima
Mi sento sempre un mix tra Leopardi e Jack Sparrow quando cerco luoghi in cui andare a scoprire nuovi sapori e nuove storie.
Mi si accende dentro un fuoco alimentato dalla curiosità di tutti i tesori e le leggende che devono ancora essere scoperte dai miei sensi e non so lasciare spazio al caso, al ripiego.
Al contrario, lo spazio lo lascio ad una ricerca minuziosa sul territorio, allo studio di ciò che può offrire con coerenza in base alla sua storia, ai consigli di amici e professionisti del settore che hanno la mia stessa visione del buono.
Per me non ci sono pasti di serie A o di serie B, ognuno merita di essere di qualità, che sia una pausa caffè, il pranzo o il dopocena.
Ho scoperto negli anni la possibilità di emozionarmi con cocktails che mescolavano dolce e salato, con coni gelato che reinterpretavano un prodotto tradizionale, con tipicità di qualità notevole gustate sopra a tovagliette e piatti di carta.
Ho scoperto che fare ricerca e farsi e fare domande è uno dei modi migliori per legare il senso del dove al senso del cosa.
La biodiversità, quella sconosciuta
206 PAT (prodotti agroalimentari tradizionali) riconosciuti, il podio delle regioni italiane più ricche di biodiversità gastronomica, un territorio ancora incredibilmente preservato, un’onestà di sapori e profumi unici nel mediterraneo.. ma il riassunto dell’esperienza gustativa che mi viene fatto più spesso da chi trascorre dei brevi periodi in Sardegna si riduce a “porceddu – seadas- pane carasau -mirto”.
Qualcuno si spinge fino a su casu marzu.
Di “su pitzudu” di Ovodda, ad esempio, quanti ne hanno mai sentito parlare?
Quanti la chiamerebbero seada prima di scoprire che invece non lo è e che la differenza sta nel ripieno di patate e formaggio chiuso tra due sfoglie di pasta violada a cui, in questo caso, si aggiungono le uova?
Quanti hanno mai sentito parlare, oltre che del pane carasau, di su civraxiu, su pistoccu, su coccoi, su zichi ladu, su pane lentu, sa spianata, sa costedda, su pan’e gherda, s’orzatu, su pane buttidu.
E ancora su guttiau, su moddizzosu..?
Dove si perde quel mosaico policromo e cangiante di riti (e ritmi) culinari, varianti simili ma distinte di piatti che in paesi e subregioni diverse cambiano nome e qualche caratteristica del loro aspetto?
Può non perdersi ma essere ritrovato, ma solo se siamo disposti a perderci noi in quelle zone dove i figli della terra e del mare, senza compromessi, hanno tramandato a voce un sap(e)ore centenario.
A disposizione del mondo metto anche la mia, di voce.
Come si custodiscono i segreti se non svelandoli piano, sottovoce, a chi li sa custodire a sua volta?
A chi alla fretta di non scegliere e mangiare dove capita, preferisce prendersi il tempo di scegliere cosa mangiare.
Perché se stai mangiando una fregula importa dove la stai mangiando, ma importa allo stesso modo sapere che “fregola” è certamente la parola scorretta per descriverla perchè in italiano significa tutt’altro e in sardo non esiste.
Importa avere un’idea generale della sua storia e delle modalità con cui viene prodotta.
Importa perché così all’atto del mangiare e basta, si unisce quello del nutrire.
Nutrire il corpo ma anche la conoscenza.
La biodiversità agroalimentare può continuare ad esistere se ci cuciamo addosso la volontà di essere biodiversi in primis come persone: vari, variabili, diversi, unici ma con l’intento comune di mantenere un equilibrio nell’eco sistema uomo-natura.
Essere risorse nel ciclo vitale di altre risorse, anziché sfruttarle a senso unico.